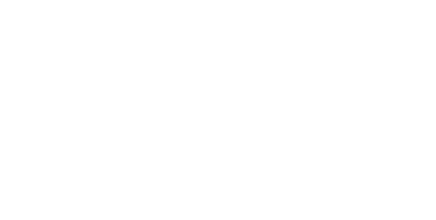Tag: Coronavirus
Ministero Beni Culturali: 11 milioni di euro per circhi e spettacolo viaggiante
Card. Bassetti: il silenzio si fa preghiera
Covid 19: oltre 200 i sacerdoti scomparsi. Tra questi alcuni impegnati nella pastorale migratoria
Card. Bassetti: daremo un nuovo contributo di carità nella campagna vaccinale
Elogio del tempo
Cei: dal 14 febbraio ripristinato segno della pace con uno cenno degli occhi e un inchino
Migrantes Trani-Barletta-Bisceglie: esperienze a margine del Sars-Cov-19 a fianco del circo
Medici malati e morti: le storie di quelli stranieri
Milano - In prima linea ci sono anche loro. Dimenticati, trascurati, discriminati persino. E a volte contagiati, proprio come gli altri. «Sono un medico. Sono albanese, di Scutari. Mi sono laureata in medicina all’università italiana di Tirana, gemellata con Tor Vergata di Roma. Ma quando, dopo essere arrivata in Italia, sono andata ad iscrivermi all’Ordine dei medici, mi hanno detto che non potevo farlo perché non avevo il permesso di lavoro. Ho risposto: 'Certo che non ho un permesso di lavoro, senza l’iscrizione da voi, non posso esercitare'. Sono ricorsa al ministero della Salute. Ci sono voluti un po’ di tempo e un bel po’ di documenti, ma alla fine ho ottenuto parere favorevole alla mia iscrizione». Artes Memelli ha 28 anni, da agosto 2017 lavora da libera professionista nel mondo dell’emergenza veneta (oggi messo in ginocchio dalla seconda ondata di epidemia): Pronto soccorso e 118. «Amo il mio lavoro, mi sono preparata per farlo. Con il Covid l’impegno è moltiplicato, ma non mi sono mai tirata indietro. Però ho paura. Non solo d’essere contagiata. Ho paura perché sono sola e, se mi ammalo, come faccio con le spese? Non ho ferie, non ho malattia».
Ai medici stranieri che arrivano in Italia non basta il riconoscimento dell’equipollenza del titolo; per lavorare nella sanità pubblica serve la cittadinanza italiana. Così si arriva al paradosso che, da una parte, nella sanità pubblica il personale è sottodimensionato, mentre, dall’altra, la legge blocca nelle strutture private 22mila medici e 38mila infermieri, perché privi della cittadinanza italiana. Per fronteggiare la pandemia, il Decreto Cura Italia di marzo 2020, all’articolo 13 ha previsto la possibilità per i medici stranieri di lavorare nel pubblico, ma solo per questo tempo eccezionale. «Il rischio è che diventi una guerra fra poveri – spiega Foad Aodi, fondatore e presidente dell’Associazione medici di origine straniera (Amsi) –. Chi lavora nelle strutture private ha un trattamento economico inferiore. Poi ci sono i liberi professionisti a partita Iva, che quindi non godono dei benefici di un contratto. Sono colleghi qualificati, ma per la legge italiana sono di serie B».
«Il Covid è stato per noi un’occasione di riscatto. I medici stranieri sono stati e sono in prima linea nei pronto soccorso, molti si sono impegnati nella Protezione Civile o nella Croce Rossa»: la dottoressa Eugenia Voukadinova, 54 anni, di origini bulgare, è in Italia da 25 anni. Specializzata in dermatologia e venereologia, lavora per un’azienda francese convenzionata con il Servizio sanitario italiano, come medico di medicina fisica e riabilitazione. «Quando arrivai qui, mi riconobbero solo i primi esami. Praticamente ho dovuto prendere un’altra laurea in medicina, e studiare in un’altra lingua non è facile. Lavoravo di giorno e di notte stavo sui libri, in più crescevo mia figlia». Anche se da sei anni è cittadina italiana, ad Eugenia lavorare nel pubblico non interessa più, ma combatte «perché i muri cadano». E lei di muri se ne intende, visto che nel 1989, armata di piccone, fu una dei tanti giovani che a Sofia contribuirono a sfondare quel muro che dal 1961 imprigionava l’est Europa. «Quell’anno l’università si fermò. Tutti noi abbattemmo il nostro pezzo di muro. Qui faccio lo stesso, mi impegno ad abbattere tanti piccoli pezzi di muro perché i nuovi colleghi non abbiano più a patire discriminazioni». (Romina Gobbo – Avvenire)