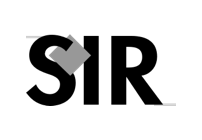Primo Piano
A settembre il Festival delle Migrazioni a Torino
Università Urbaniana: parte il corso in Religioni e Dialogo interreligioso
Studenti internazionali: una scuola dedicata a Giorgio La Pira in Angola
Vangelo Migrante: XVII Domenica del Tempo Ordinario | Vangelo (Lc 11,1-13)
Spettacolo Viaggiante: oggi mons. Pizziolo alle giostre di Oderzo

Papa Francesco: il card. Lojudice guiderà anche la diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza
Dipartimento Usa: “quattro milioni di sfollati a rischio tratta”
Inclusione digitale, responsabilità formativa

Leopoli capitale dei rifugiati: “l’esodo non si è fermato”
Leopoli - Non sono valigie di viaggiatori o turisti quelle che ancora si vedono alla stazione di Leopoli. Nell’atrio e nel piazzale di fronte si continua ad arrivare per fuggire dalla guerra ma anche per rientrare in Ucraina. Le partenze non hanno certo i numeri dei primi giorni del conflitto quando, come raccontano qui, «la città era un immenso aeroporto dove tutti si muovevano lungo le strade con valigie, zaini e sacchetti in mano». Ma l’esodo prosegue: soprattutto dall’Est e dal Sud del Paese, dove ai missili russi che cadono ogni giorno si aggiungono gli appelli delle autorità all’evacuazione delle zone “ad alto rischio”. E si lascia ancora il Paese. Non con i treni perché sono stati cancellati i convogli che collegano la città con la vicina Polonia, a meno di settanta chilometri. Ma con gli autobus che partono a decine ogni giorno. Verso Cracovia, verso Varsavia, persino verso il Portogallo. Ma anche per Kiev dove c’è chi ha scelto di tornare. Appena fuori la stazione tre gazebo sono i punti di primo soccorso per chi ha lasciato tutto. I volontari offrono tè freddo o piccoli panini. Accampati, nelle panchine intorno, tutti coloro che sono in attesa del loro futuro prossimo.
Certo, Leopoli resta la “capitale” dei rifugiati. Su poco meno di un milione di abitanti, i profughi sono 200mila: un quinto della “sua” gente. Sistemati ovunque: in edifici pubblici, nelle famiglie, nelle parrocchie ma soprattutto nelle scuole e nelle palestre. E adesso si profila un’emergenza nell’emergenza. «L’amministrazione comunale – racconta l’arcivescovo Mieczyslaw Mokrzycki che guida la Chiesa di rito latino – ha stabilito che dal 1° settembre riprendano le lezioni. E la domanda che tutti si fanno è: dove andranno quanti sono alloggiati nei plessi e negli impianti sportivi? Perché ogni scuola ha la sua palestra. E non solo vanno liberate le aule ma anche le strutture connesse. Si parla di migliaia di rifugiati da ricollocare». Per ora la risposta non c’è.
Ma c’è il “terrore” dell’inverno. Le temperature scendono fino a venti gradi sotto zero. «Si ipotizzano già problemi per il riscaldamento – spiega Mokrzycki –. E vale anche per noi come arcidiocesi che stiamo accogliendo oltre 4.500 sfollati in molte strutture sparse sul territorio. Però alcune diventano inadeguate quando le temperature crollano».
Appena dietro il palazzo arcivescovile il parco dedicato al padre culturale dell’Ucraina, Taras Shevchenko, è un gigantesco hub dell’ospitalità. Il dipartimento di fisica dell’Università con la sua palestra ha aperto le porte a centocinquanta famiglie. Si dorme sui materassi poggiati sopra il pavimento e su qualche bancale; si stendono i panni nei fili che vanno da un canestro alla pertica; si mangia su due casse di legno trasformate in tavola.
«È difficile vivere così – sostiene l’arcivescovo –. Se poi aggiungi il fatto che hai già esaurito tutti i risparmi e non hai un lavoro, la situazione è al limite della sopportazione. Per questo si sceglie di tornare. Almeno una famiglia ritrova la sua terra». In un angolo del parco è nato l’unico “villaggio prefabbricato” di Leopoli: l’ha donato il governo polacco, come indica la bandiera che al cancello sventola accanto a quella ucraina. Cinquantasei container con tre posti letto ciascuno sono le case dei rifugiati. Ma niente cucine e bagni: quelli sono in comune. Una mamma allatta un piccolo di pochi mesi mentre altri due figli giocano sull’asfalto. Accanto un anziano sulla sedia a rotelle si riscalda al sole. «Sono salvo – sussurra –. È ciò che conta di più». (Giacomo Gambassi - Avvenire)
Migranti: 33.817 le persone sbarcate sulle coste italiane
Sant’Egidio: un anno di impegno collettivo che ha incluso nella campagna vaccinale migliaia di persone considerate “invisibili”
Mons. Chomali: “vergogna e impotenza per la morte di tre venezuelani in un container, fa male vedere l’indifferenza”

Unhcr: ripreso il programma di rimpatri volontari di congolesi dall’Angola
Vescovo e migrante
Washington: studenti e insegnanti italiani all’Ambasciata d’Italia
Ministero Lavoro-Anci: pubblicato rapporto si insediamenti informali dei migranti
Roma - Almeno 10mila lavoratori agricoli migranti vivono in insediamenti informali in Italia. Luoghi di privazione dei diritti e sfruttamento, in molti casi presenti da diversi anni, privi di servizi essenziali e di servizi per l’integrazione. È l'evidenza più critica del Rapporto “Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare” pubblicato oggi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nell’ambito del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020–2022.
Il Rapporto, realizzato dalla Fondazione Cittalia dell’ANCI presenta i risultati di un’indagine senza precedenti per copertura nazionale e ampiezza di restituzione. La metà dei Comuni italiani ha compilato un questionario su presenze, flussi, caratteristiche dei lavoratori agricoli migranti e sistemazioni alloggiative: dalle abitazioni private e strutture, temporanee o stabili, attivate da soggetti pubblici o privati, fino agli insediamenti informali o spontanei non autorizzati. Sono stati censiti anche i servizi a disposizione degli ospiti, così come gli interventi per l’inserimento abitativo promossi dai Comuni stessi. Sono 38 i Comuni che hanno segnalato la presenza di 150 insediamenti informali o spontanei non autorizzati, con sistemazioni varie (casolari e palazzi occupati, baracche, tende e roulotte) e presenze che vanno dalle poche unità registrate nei micro-insediamenti, alle migliaia di persone nei “ghetti” più noti alle cronache. Alcune aree del Meridione guidano la classifica delle undici Regioni coinvolte, ma il fenomeno interessa tutto il Paese. L’indagine ha consentito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di individuare anche le amministrazioni locali destinatarie dei 200 milioni di euro del PNRR investiti con l’obiettivo di superare questi insediamenti. Lo rendono noto l'Ufficio stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e quello dell’Anci.
Migranti: 33.556 persone sbarcate sulle coste italiane
Scuola: 65%degli stranieri è nato in Italia
Burocrazia e nessuna legge “La cittadinanza? Un sogno”
Terni - Storie di ordinaria burocrazia. E di diritti negati per le storture di una legge che oggi li condanna a sentirsi stranieri in quello che è a tutti gli effetti il loro Paese. Jurgen, Alexia e Doris sono tre esempi emblematici di come lo Ius scholae, ora fermo alle Camere, risolverebbe il problema alla radice. Hanno età e situazioni diverse, ma sono uniti dallo stesso filo rosso. Sono 'italiani senza cittadinanza'.
Jurgen Kulli ha 24 anni ed è nato a Spoleto da famiglia albanese che non ha mai chiesto la nazionalità italiana. «Quando i miei genitori divorziarono – spiega – mio padre, che aveva in carico i documenti, non rinnovò il mio permesso di soggiorno e quindi io ho vissuto da irregolare nel mio Paese, fino a 18 anni, senza rendermene conto. Frequentavo la scuola dell’obbligo e quindi non potevano espellermi, così come mia madre, che viveva qui con due figli a carico. Diventato maggiorenne ho fatto richiesta per la cittadinanza: con il mio avvocato Suzana Korriku abbiamo presentato tutti i documenti che certificavano il fatto che io sono nato qui e non sono mai uscito dall’Italia. Niente. Ho anche chiesto al prefetto: 'Mi faccia una prova di italiano', ma non c’è stato verso». Oggi Jurgen, che lavora in una impresa edile, ha un permesso umanitario, ottenuto a fatica e deve rinnovarlo ogni anno, fino a quando, a 30 anni, potrà ottenere la cittadinanza. E intanto, trova ostacoli ovunque. «Vorrei tanto fare il concorso per entrare in Polizia, ma non posso, perché non sono italiano» dice.
Alexia Miranda Cedono ha 18 anni ed è nata a Foligno, da famiglia originaria dell’Ecuador. Oggi studia all’Università e lavora in un fast food, ma questo non basta per garantirle la cittadinanza. Nel suo caso, alla burocrazia si unisce il destino, in una combinazione che oggi la costringe a dover stare attenta a non perdere mai il lavoro: «Il mio permesso di soggiorno è per motivi di lavoro e se lo perdo, potrebbero rimandarmi in Ecuador, dove io non saprei che fare», spiega. Tutto comincia nel 2016, quando i genitori decidono di tornare in Ecuador, portando con loro Alexia ed i due fratelli. Doveva essere una permanenza breve, ma fra un problema coi documenti, uno economico ed il lockdown, restano nel Paese sudamericano cinque anni. «A me mancava la pasta, io mi sono sempre sentita straniera in Ecuador, ho tenuto l’Italia nel cuore tutto il tempo – dice Alexia –. però avevo 12 anni, non potevo farci niente, decidevano i miei genitori». Questa lunga sosta, per la legge italiana, le impedisce, oggi che è maggiorenne, di poter richiedere la cittadinanza. «Io e i miei fratelli siamo paradossalmente 'vittime' della decisione dei nostri genitori – spiega –. Ho dovuto rifare da zero il permesso di soggiorno ed oggi ce l’ho per motivi di lavoro, rinnovabile anno dopo anno. L’Università? Per lo Stato non conta, perché non fa parte dei percorsi di istruzione obbligatoria». Anche per lei, ci vorranno dieci anni di residenza o il matrimonio con un italiano.
Ma la storia più paradossale è quella di Doris Egwu, 39 anni, nata in Nigeria e trasferitasi in Umbria da quando aveva otto mesi. Anche lei lavora ed è attivista per i diritti degli 'italiani senza cittadinanza' presso l’associazione Il Pettirosso. La sua domanda di cittadinanza è bloccata dal casellario giudiziale. Ma non quello italiano, bensì quello nigeriano: «In Italia, dove la responsabilità penale comincia a 14 anni, mi chiedono un documento che attesti che io non abbia commesso reati quando avevo da zero a 8 mesi, in Nigeria». Non solo: «Siamo già al terzo tentativo: prima è arrivato scaduto, poi è arrivato in inglese ed è scaduto per i tempi lunghi della traduzione in Italia. Quando tornerò in Nigeria proverò ad ottenerlo, ma non sarà facile perché l’anagrafe là non funziona bene. I miei genitori non hanno mai voluto fare richiesta ed io stessa ho capito che serviva quando è morto mio padre. Avevo 19 anni e non mi ero mai mossa dall’Italia, ma purtroppo mancava un requisito: mia madre infatti aveva sempre lavorato in casa, era mio padre che manteneva la famiglia. Ha iniziato a lavorare in quell’anno, dopo la morte di mio padre». È qui che entra in gioco la distratta burocrazia italiana: «Passati cinque anni, avevamo tutto in regola, ma quando siamo andati a fare richiesta abbiamo scoperto che secondo lo Stato italiano avevamo vissuto per un periodo in Nigeria, io e mio fratello, senza mia madre, quando lui aveva 5 mesi ed io ero al nido. In realtà ci eravamo solo trasferiti da Perugia a Terni, con la famiglia». Oggi, sua madre e suo fratello sono riusciti ad ottenere la cittadinanza mentre Doris attende ancora il documento e nel frattempo può restare in Italia perché «familiare di un convivente con cittadinanza italiana». Maledetta burocrazia. (Emanuele Lombardini - Avvenire)